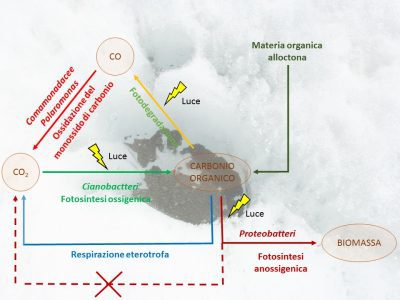 |
| 3. I metabolismi del carbonio sulla superficie dei ghiacciai studiati |
Milano, 10 maggio
2016 – La vita sui ghiacciai è molto più complessa di quanto non si pensi. Una
squadra di studiosi guidata da ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca ha
scoperto che sul ghiacciaio dei Forni in Italia e su quello del Baltoro nel
Kashmir i metabolismi energetici e del carbonio attivi sulle superfici
ghiacciate non sono due ma quattro: respirazione, fotosintesi ossigenica, un
altro metabolismo fotosintetico che non produce ossigeno e, infine,
l’ossidazione del monossido di carbonio.
Per arrivare a
questi risultati, i ricercatori del DISAT(Dipartimento di Scienze dell’Ambiente
e del Territorio e di Scienze della Terra dell’Università di Milano-Bicocca)
coordinati da Andrea Franzetti e Roberto Ambrosini, in collaborazione con alcuni
colleghi dell’Università degli
Studi di Milanoe
dell’Accademia delle Scienze
Bavarese, hanno utilizzato tecniche
avanzate di sequenziamento del DNA e tecnologie di supercalcolo. La scoperta,
appena pubblicata sulla rivista ISME
Journaldel gruppo Nature (Doi:
10.1038/ismej.2016.72), ha importanti implicazioni: se la presenza di questi
metabolismi alternativi fosse verificata in tutte o nella maggior parte delle
aree ghiacciate del mondo – che formano complessivamente il 10 per cento delle
terre emerse – sarebbe necessario ricalcolare il contributo complessivo dei
ghiacci a fenomeni di importanza cruciale come l’effetto serra e il
riscaldamento globale.
Fino ad oggi si
pensava che i metabolismi dei batteri sui ghiacciai fossero due: la fotosintesi
ossigenica che, come la fotosintesi clorofilliana studiata a scuola, vede i
microrganismi consumare anidride carbonica (CO2) ed energia solare
per produrre ossigeno, e la respirazione, con la quale utilizzano ossigeno e
sostanza organica producendo CO2. Invece, ne sono stati individuati
quattro: oltre ai due precedenti, un diverso metabolismo fotosintetico che non
produce ossigeno, con il quale alcuni tipi di microrganismi usano la sostanza
organica per crescere prendendo energia dalla luce del Sole, e l’ossidazione del
monossido di carbonio (utilizzato dai batteri per crescere), che in quegli
ambienti viene prodotto attraverso la degradazione della sostanza organica da
parte dell’intensa luce solare.
Gli ecosistemi
studiati sono il ghiacciaio dei Forni, in Lombardia, che negli ultimi decenni si
è ritirato visibilmente, e il ghiacciaio del Baltoro, nel Kashmir, sul versante
pakistano, che come molti altri ghiacciai della zona tende a rimanere più o meno
stabile, configurando il fenomeno noto come “Anomalia del
Karakorum”.
È il primo studio al
mondo ad applicare tecniche di sequenziamento massivo del DNA ai sedimenti
sovraglaciali. Con una dozzina di provette, riempite a 2700 metri di altitudine
sul ghiacciaio dei Forni e a 5000 metri sul ghiacciaio del Baltoro, contenenti
materiale estratto da piccole buche nel ghiaccio di origine naturale – le
coppette crioconitiche – oggi è possibile controllare la “carta d’identità”
genetica dell’intero ecosistema e ricostruire il suo metagenoma, ovvero il DNA
di tutto ciò che vive sulla sua superficie. Un “data set” enorme, utilizzabile
per molti altri studi: si va da una tabella da un milione e mezzo di righe con
frammenti di Dna, ad un Terabyte di dati ricombinati e interpretati seguendo
metodi scientifici. L’analisi, infatti, avviene mediante moderne tecniche di
sequenziamento e bioinformatica, grazie all’incredibile potenza di calcolo di
server come quelli del Consorzio interuniversitario Cineca: il loro nome in inglese è Next-generation sequencing:
sequenziamento massivo o parallelo, letteralmente, “di nuova
generazione”.
L’importanza di
questi studi è dovuta anche al fatto che i ghiacciai non sono mondi a sé, ma
influiscono sugli ecosistemi abitati a valle e si comportano come “frigoriferi
naturali”: gli inquinanti, nel ghiaccio, vengono conservati proprio come in un
freezer e in alcuni casi vi si
possono ritrovare ancora oggi tracce di DDT, nonostante in Europa l’insetticida
sia stato bandito da decenni. I batteri che vivono nel ghiaccio possono influire
su vari processi chimici e fisici; la crescita batterica, inoltre, ha un impatto
sensibile sull’annerimento del ghiaccio che, a sua volta, influisce sulla
velocità con cui i ghiacciai fondono, mentre il bilancio dei metabolismi del
carbonio influenza il contributo dei ghiacciai all’effetto
serra.
I dati raccolti
permettono di puntare verso altri obiettivi ambiziosi, già nel mirino dei
ricercatori: uno dei più importanti è lo studio del rapporto fra batteri e
inquinanti, mentre un altro riguarda la dispersione nell’ambiente di
microrganismi resistenti agli antibiotici, un problema emergente dal punto di
vista chimico e da quello medico.
«I ghiacciai non
sono ambienti privi di vita – spiega Roberto Ambrosini – ma ospitano complesse
comunità formate soprattutto da batteri. La loro crescita e i loro metabolismi
possono avere un notevole impatto sull’annerimento, sullo scioglimento del
ghiaccio e sul mantenimento di funzioni ecologiche essenziali per gli ecosistemi
a valle».
«Queste comunità
batteriche – sostiene Andrea Franzetti – sono ancora più versatili di quanto
ipotizzato sinora. La luce non permette solo la fissazione dell’anidride
carbonica, ma supporta le esigenze energetiche di altri microrganismi tramite un
processo di fotosintesi aerobica anossigenica. Dove la radiazione solare è
intensa, inoltre, è possibile trovare batteri capaci di completare l’ossidazione
del monossido di carbonio ad anidride carbonica».


